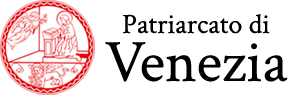Incontro ecumenico nella Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(Venezia – Basilica Cattedrale di San Marco, 23 gennaio 2026)
Intervento del Patriarca Francesco Moraglia
Cari fratelli e sorelle in Cristo,
desidero esprimere gratitudine – a nome della Chiesa di Venezia – alla Chiesa Armena, per ciò che ha rappresentato e rappresenta nel composito mosaico della cristianità universale, e alla Congregazione Mechitarista di Venezia che ha svolto e ancor oggi svolge il ruolo di importante ponte di comunicazione tra la Chiesa Apostolica d’Armenia e la Chiesa Cattolica, secondo il carisma impressole dal Fondatore, il servo di Dio Abate Mechitar, del quale abbiamo avuto la gioia di riaprire la causa di canonizzazione felicemente conclusasi, nella fase diocesana, l’8 settembre 2022.
Fermiamoci ora sul passo di Efesini che guida quest’anno la settimana ecumenica. L’apostolo Paolo scrive esortando all’ «unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,3). Parole oggi attualissime: radicate nella carità di Cristo, unità e pace si richiamano, poiché l’unità è opera della pace e la pace esprime ed è frutto dell’unità.
Nel nostro tempo così martoriato, in cui l’umanità sembra fallire sia nel percorrere la strada dell’unità e della pace, dobbiamo avere il coraggio di parlare di pace e unità come unica cifra antropologica possibile e come inclinazione di ogni cuore, anche quando sembra tutto perduto, là dove tutto sembra prendere una strada diversa. La vera partita si gioca impegnandosi per l’unità, la bontà, la verità.
Già il pensiero classico – con Parmenide e, in maniera più articolata, con Platone – era pervenuto ad affermare la superiorità dell’uno sul molteplice e all’assimilazione dell’unità e dell’essere al bene e al bello. L’unità è assimilata all’opera di verità e di bene: unum, verum, bonum. Questo pensiero, sviluppato da Agostino nella sua visione della creazione tutta attraversata da queste qualità in quanto procedenti da Dio, rimarrà patrimonio della riflessione filosofica e teologica della fede cristiana.
L’unità e la pace sono esigenze intime della fede cristiana e del nostro essere Chiesa. Esse rimandano a Cristo, lo testimoniano e manifestano.
Nel 1172 san Nerses Shnorhali, Catholicos della Chiesa Armena e pioniere dell’ecumenismo, scrive al Patriarca di Costantinopoli Michele III: «Questa pace ci è stata cara fin dall’infanzia e noi desideravamo raggiungerla, soprattutto quando vedevamo che i nostri e i vostri sapienti, incontrandosi, non dicevano, da una parte come dall’altra, parole distanti dai maestri ortodossi; a loro mancava soltanto “l’amore, vincolo della perfezione” (Col 3,14), madre della pace, ma non “l’abilità di parola, che rende vana la croce di Cristo” (1Cor 1,17), secondo l’Apostolo».
Dello spirito ecumenico di san Nerses Shnorhali si fece carico, reinterpretandolo nel suo tempo, più di cinque secoli dopo, l’Abate Mechitar di Sebaste, il quale realizzò a Venezia il centro dal quale ebbe impulso la rinascita della cultura armena in tutto il mondo e un nuovo stile e spirito di rispetto e feconda amicizia tra le Chiese Armena Apostolica e Cattolica.
Cristianità di frontiera è quella della nazione armena – la prima ad avere accolto come tale la fede cristiana e ad averne fatto la fonte d’ispirazione dell’intero organismo della propria cultura – e nella sua autenticità è al tempo stesso una cristianità martiriale, ossia plasmata nel sangue della testimonianza del santo Battesimo.
La cristianità armena ha testimoniato e continua a testimoniare questa indole, questa identità e appartenenza, sotto la pressione di persecuzioni che – senza interruzione – si sono susseguite nella storia di una terra che è stata un importante crocevia di popoli e culture ma, proprio per questo, è anche sempre sottoposta a tensioni e mire di potenze contendenti.
In tali persecuzioni ha visto il proprio popolo sottoposto a programmi di sterminio, spesso nell’indifferenza dell’Occidente, e pure la deliberata distruzione delle proprie memorie materiali: delle sue antichissime architetture, delle magnifiche croci scolpite nella pietra che, raffigurando l’Albero della Vita nella sua fioritura primaverile, presentano la Croce come ragione di speranza e di vita eterna. Uccidendo la memoria si vuole uccidere due volte.
La spiritualità del popolo armeno, con la sua riflessione teologico-sapienziale, è decisamente “staurocentrica”, ossia pone la croce al centro. “Staurocentrica” come lo sono l’architettura, l’arte figurativa, la letteratura e la musica – soprattutto nella loro espressione poetica e innodica liturgica –, e tutto ciò che è espressione della sua cultura.
È sintomatico che l’antico alfabeto armeno – creato nel 405 dal monaco san Mesrop Mashtoz e composto da 36 lettere – cominci con una lettera (Ա – A) che richiama l’iniziale di Astvadz (il nome di Dio in lingua armena) mentre l’ultima (Ք – K) è l’iniziale di Kristos: tutto è qui compreso e c’è in mezzo tutta la possibilità dell’uomo di esprimersi, di comunicare e di dialogare.
Popolo della Croce, il popolo armeno sembra sia chiamato alla testimonianza della Croce incarnata e vissuta, in una sorta di condizione di “martirio”: testimonianza radicale e ultimativa come versamento di sangue, nella quale pure conferma e rigenera la propria fede anche se, soprattutto nella diaspora, risente oggi dello spirito del secolarismo senza, però, spingersi all’ingratitudine del disprezzo delle proprie radici che le rimangono care anche se, nelle singole persone, la fede può essersi smarrita.
Non manca – e su di essa desidero soffermarmi – la riflessione teologica sul senso di tale condizione, sviluppata solo negli ultimi decenni, a partire dagli anni ’90 del ‘900 (da Viken Guroian, 1991 e 1995; Grigoris Balakian, 2010; Shushan Khachatryan, 2012), ossia dopo le analoghe riflessioni della teologia ebraica – ma anche cristiana, in ambito luterano e cattolico – sulla Shoah. E questo, forse, perché la spiritualità staurocentrica del popolo armeno da sempre offre criteri ermeneutici per una più naturale elaborazione della tragedia.
Essere di Cristo sino a trovarsi, con Lui, infissi sulla sua stessa Croce. Ed essere anche dimenticati e traditi, come Lui, anche da fratelli e amici, da cristiani e da un Occidente sprofondato nel suo indifferente benessere.
Eppure vincere. Vincere secondo l’amore con cui Cristo rovescia le logiche di violenza del mondo. Quell’amore che chiede unità e pace e ci chiama alla responsabilità di essere, come abbiamo ascoltato dall’Apostolo, «un corpo solo e un solo Spirito», essendo «chiamati a una sola speranza», giacché «vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti» (Ef 4,4-6).
Vent’anni orsono – era il 28 maggio 2006 – Papa Benedetto XVI fu pellegrino ad Auschwitz. Le parole iniziali di quel discorso sono più che mai attuali. Siamo in un tempo in cui la politica ha smarrito il senso del diritto internazionale e, ancor prima, della moderazione, della giustizia e della riconciliazione di fronte ai contrasti, per quanto gravi siano le motivazioni.
Benedetto XVI lo uniamo idealmente a san Giovanni Paolo II (1979) e a Francesco (2016), anch’essi pellegrini in quel campo di sterminio che dice in modo eloquente uno dei volti diabolici del nazismo.
Diabolica, perché luogo della divisione dove si voleva prima di tutto distruggere (de-costruire), l’uomo. La rivelazione biblica ha un punto fondamentale nella rivelazione del nome di Dio che avviene per un popolo che soffre: «Ho visto, ho visto l’afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori; infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo» (Es 3,7-8). Al capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, poi, più volte Gesù dice di essere venuto a rivelare il nome del Padre (cfr. Gv 17,6.12.26). Ad Auschwitz, invece, le persone erano solo dei numeri; non esistevano i nomi. E viene qui in mente quella pagina dell’Apocalisse di Giovanni (13,18) in cui è rivelato il nome della “bestia” (ossia il diavolo / l’anticristo); un nome che, in realtà, è proprio un numero: 666.
Auschwitz come volto e luogo diabolico, dunque, perché contro Dio e contro l’uomo che è immagine di Dio; un vero “luogo di orrore e crimini contro Dio e l’umanità” costruito appositamente per distruggere ogni forma di umanità e rispetto, dove Papa Benedetto pregò e meditò sull’immenso male dell’Olocausto e sulla necessità di memoria e dialogo.
Ecco le sue parole: «In un luogo come questo vengono meno le parole, in fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio – un silenzio che è un interiore grido verso Dio: Perché, Signore, hai taciuto? Perché hai potuto tollerare tutto questo? È in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti alla innumerevole schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte; questo silenzio, tuttavia, diventa poi domanda ad alta voce di perdono e di riconciliazione, un grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa» (Benedetto XVI, Discorso del Santo Padre in visita ad Auschwitz- Birkenau, 28 maggio 2006). Parole che, pur nella diversità delle situazioni, ricordano il travaglio del popolo armeno e di tanti altri popoli perseguitati.
L’impegno è di conservare oggi vive – nelle nostre chiese e comunità – queste domande sulla necessità del perdono e della riconciliazione: a Gaza, in Ucraina e negli altri sessanta teatri di guerra oggi attivi nel mondo. L’impegno è quello di portare nella nostra preghiera i 390 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. L’impegno è di conservare e tenere vive, nelle nostre chiese e nelle nostre comunità, queste domande sulla necessità del perdono e della riconciliazione.
Anche attraverso questa preghiera ecumenica, Dio tenga viva in noi la consapevolezza che esiste – come ricorda il testo di Efesini – un’unica strada percorribile, ossia «conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (Ef 4,3). Ogni altra strada è menzogna!