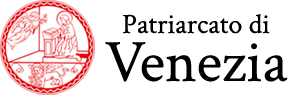Dies academicus della Facoltà Teologica del Triveneto nel ventennale della fondazione
(Padova, 18 febbraio 2025)
Prolusione del Gran Cancelliere e Patriarca di Venezia Francesco Moraglia
“QUALE CULTURA PER L’EUROPA? RAGIONI DI SPERANZA NEL TEMPO DELLO SMARRIMENTO:
INTERPRETARE IL PRESENTE, PROGETTARE IL FUTURO”
Eccellenze, autorità civili e militari, Vice Gran Cancelliere, Signor Preside e autorità accademiche, cari docenti e studenti e voi tutti oggi qui presenti,
accogliendo l’invito a tenere la prolusione per il Dies academicus della Facoltà Teologica del Triveneto nella ricorrenza del suo ventesimo anno d’erezione (2005/2025), ho pensato fosse utile interrogarsi sulla complessa e lacerata cultura contemporanea in cui la nostra Facoltà opera a servizio delle Chiese e comunità civili del Nordest, mettendo in gioco le sue competenze e il suo sensus Ecclesiae.
La Facoltà è comunità di docenti e studenti e s’impegna a servizio del sapere scientifico (didattica e ricerca) considerando la realtà in tutte le sue dimensioni; sì, è un laboratorio di cultura filosofica e teologica che si applica e non si adatta in modo acritico alle affascinanti sfide che la cultura oggi ci propone. Infatti, nell’epoca delle tecnoscienze e, in specie, dell’Intelligenza Artificiale, si deve guardare con empatia l’uomo, come chiede il pensiero di Cristo che anima il nostro essere e si fa pure nostro pensiero[1]. Risuona alta la voce del beato Antonio Rosmini: «Abbiamo bisogno di pensare in grande!»[2]; tale richiesta è un’esigenza, non un auspicio o una possibilità; no: “Abbiamo bisogno di pensare in grande!”.
Il tentativo è di delineare alcuni tratti essenziali, riguardanti la cultura odierna, le sue spinte epocali e, in questo tempo di smarrimento, cogliere così le “ragioni della speranza” che ci trattengano dal cadere, a nostra volta, nello smarrimento. Dato che questo è il tempo che ci è dato vivere sarebbe irrealistico rifiutarlo o pensare d’attraversarlo indenni. Abbiamo, piuttosto, il desiderio di abitarlo qualunque ne siano le criticità; è il primo passo per essere all’altezza e così costruire sulle eventuali derive.
Non si orienta correttamente la vela se non si valuta bene la direzione del vento che il marinaio esperto sa calcolare, per cui anche il vento contrario può diventare punto di forza nella navigazione e aiutare a muovere nelle differenti direzioni. A partire dagli elementi critici bisogna conoscere le istanze di autenticità sottostanti, bonificandole dalle eventuali distorsioni che portano fuori strada. Il vento, in qualsiasi direzione spiri, rimane una forza e, così, le spinte che animano la cultura contemporanea possono, a loro volta, diventare punti di forza. Il Vangelo, già nei primi secoli, ha rigenerato la cultura classica; anche la cultura del nostro tempo può essere rigenerata dai valori evangelici e diventare fattore di novità a partire dagli aneliti di bontà, bellezza e verità oggi presenti e tutto ciò tramite una visione costruttivamente critica.
Cercare le ragioni della speranza significa, innanzitutto, non disperare del nostro tempo gravato da crescenti conflitti planetari, in una situazione geopolitica preoccupante che moltiplica smarrimento ed incertezza.
Di un tale smarrimento ed incertezza sono segni eloquenti tanto la perdita di senso nell’agire, quanto la confusione delle coscienze chiamate a discernere, sia le frequenti e gratuite violenze che dicono mancanza di consapevolezza. Viene alla mente la “banalità del male” come la descrive Hannah Arendt[3]. A tutto ciò si aggiunge, poi, il giudizio negativo sull’Occidente come se ad esso andasse attribuito quanto di peggio ha prodotto l’umanità[4].
Segnato da tali laceranti tensioni, l’uomo avverte in sé la vocazione a superarle a partire dalla voce dell’interior intimo meo et superior summo meo[5] che, in sant’Agostino, addita la presenza di Colui che, mentre si fa più interiore della stessa intimità della coscienza, nel medesimo tempo si pone al di sopra della più elevata sommità della persona umana, la trae a sé e la invita ad andare oltre le proprie miserie, le proprie ferite, le proprie cadute. Perché la Salvezza è una realtà che precede e sovrasta, invita e convoca, non è qualcosa che ci diamo da noi stessi, per quanto tutti, consapevolmente o meno, vi tendiamo. Non è mera astrazione concettuale ma incontro vivo ed esistenzialmente pregnante col Volto del Signore che rivela il Padre e convoca alla partecipazione della vita trinitaria.
In un recente passato, nello sviluppo della cultura della modernità occidentale, l’uomo ha preteso immanentizzare tale salvezza trasferendola dalla trascendenza (che pure trasfigura e salva la vita presente) al piano materiale, all’essere nel mondo. Ciò che si rivelò più illusorio e distruttivo, fu credere di potere realizzare la salvezza da sé. Sorsero da questa radice socialismi e nazionalismi, animati dall’illusione del perfettismo politico. L’illusione, cioè, di poter realizzare il paradiso in terra e di poter superare, nella condizione terrena, la finitezza e le ingiustizie. Così, la pretesa di una salvezza umanitaristica è all’origine delle peggiori dittature, discriminazioni e violenze, segnata dal dissolvimento della responsabilità personale e della dignità della persona nella società di massa.
Possiamo cogliere nella depersonalizzazione della società, da parte di tali surrogati salvifici, una delle contraddizioni della modernità e della contemporaneità o il paradossale (e a suo modo coerente) esito dell’evoluzione del principio di soggettività personale, spinto nella collettività sociale a farne un organismo individuale, una proiezione dell’Io che, nella sua unità fondamentale, una volta trasferito alla società strutturata di una Nazione, ne decreta una unità monolitica che dissolve la complessità dell’universo sociale, diversificato nelle individualità dei singoli che la compongono.
Rivisitando lo sviluppo della cultura moderna, troviamo alle sue origini e come fondamento – l’intimo principio animatore che ne ha determinato il corso – il principio della soggettività e della sua crescente assolutizzazione che finisce per sostituire il principio-persona, mentre tenta di interpretarlo e dargli una rinnovata comprensione.
Così, se il principio-persona ha un respiro relazionale che riguarda l’intero senso, il principio-soggettività come chiave di lettura dell’individuale antropologico spezza l’unità dell’esperienza nella dialettica contrapposizione del ”sé” a tutto ciò che è ”altro”, perché al soggetto si oppone l’oggetto, all’io ciò che gli sta di fronte. L’esperienza viene dunque a configurarsi come un essere-di-fronte al mondo (e a Dio), non più come un essere-nel mondo tra persone, in relazione alle persone e a Dio, secondo il modello che rispecchia più fedelmente la logica cristiana della vita nella condizione dell’incarnazione, partecipando della dimensione finita del creato e dell’assunzione responsabile dei suoi limiti e della comunicazione con Dio anche nella vita sacramentale.
Lo sviluppo graduale del principio-soggettività ha finito per minare l’universo delle relazioni umane, per almeno due ragioni. La prima, perché il dilagare dell’io ha inevitabilmente finito per entrare in conflitto col rispetto dovuto alle soggettività “altre”, sino a invaderne gli spazi, ad intaccarne in mille forme la stessa dignità. La seconda ragione, perché tale paradigma di frontalità rispetto al mondo, di opposizione oggettivante io/non io, soggetto/oggetto, si è tradotto in un’inevitabile riduzione oggettuale dell’altro, oltre che del mondo naturale, sino alla neutralizzazione dell’intero campo dell’esperienza.
Ne abbiamo obiettivo riscontro nella profonda solitudine dell’uomo del nostro tempo, una solitudine apparentemente smentita ma, in realtà, aggravata dalla complessità della rete e delle connessioni che ci proiettano in una esasperata e vuota comunicazione a tutto campo che rende le relazioni evanescenti nel momento in cui, invece, pare – e così avviene di fatto – moltiplicarle e facilitarle.
La relazione smaterializzata, disincarnata, del vivere comune del nostro tempo è uno degli esiti del soggettivismo individualistico che segna la parabola della modernità. Una relazione smaterializzata è leggera e non impegnativa. Finisce insensibilmente per alienarci dalla concreta e sofferta complessità delle relazioni reali vissute nella presenzialità fisica, di un’esperienza “in carne e ossa” che, di fatto, mostra tutti i segni di una crescente problematicità, sino all’incapacità di essere governata.
Václav Havel, in un discorso scritto per l’Università di Tolosa nel 1984 ma pronunciato in quella sede dal drammaturgo inglese Tom Stoppard (essendo egli impossibilitato, in quanto dissidente, da poco scarcerato, a lasciare la Cecoslovacchia), additò le cause dell’alienazione culturale contemporanea tanto nella dissociazione dell’uomo moderno dal “mondo naturale” – qualificato nella filosofia del Novecento come Lebenswelt (alla lettera “mondo vitale”) – quanto nella costruzione astratta di un’interpretazione razionalistica, prodotta da una mens tecno-scientifica che avrebbe finito per neutralizzare il campo di senso dell’esperienza viva, in ciò che ha di più propriamente umano, consegnando la vita alla sterilità delle astrazioni protocollari. Fino a riconoscere nei regimi totalitari l’espressione di questa alienazione dal mondo reale dell’esperienza, nutrita da quelle coordinate elementari di senso che la precedono e ne rappresentano lo sfondo originario, rimandando al tempo stesso a un’ulteriorità indisponibile al potere di manipolazione e di inquadramento dei saperi tecno-scientifici. Al contrario, afferma Havel, «il nostro “Io” attesta primitivamente [nel senso di originario] quel mondo e intimamente lo certifica; si tratta del mondo della nostra esperienza vissuta, un mondo non ancora indifferente, dal momento che siamo intimamente legati ad esso dal nostro amore, odio, rispetto, disprezzo, tradizione, dai nostri interessi e da quella significatività preriflessiva da cui la cultura si è originata»[6].
Su questa linea di riflessione si svilupperà anche la sensibilità ambientale di Václav Havel, il quale evoca il ricordo di gioventù di una ciminiera che in campagna si elevava da una fabbrica a imbrattare il cielo di un denso fumo brunastro quale «simbolo di un’era che cerca di trascendere i confini del mondo naturale e le sue norme e di renderlo un interesse meramente individuale. […] È il simbolo di un’epoca che nega l’importanza vincolante dell’esperienza personale, così come l’esperienza del mistero e dell’assoluto e sostituisce l’assoluto personalmente esperito quale misura del mondo con un nuovo, artefatto assoluto, privo di mistero, […], impersonale e inumano. È l’assoluto della cosiddetta oggettività: la cognizione razionale e oggettiva del modello scientifico del mondo»[7].
Sono passati quarant’anni dal discorso di Havel e queste parole paiono oggi – in cui ad ogni livello si parla di Intelligenza Artificiale – attualissime e percepibili nell’esperienza quotidiana, sintomo di una sterilizzazione delle relazioni, della disumanizzazione delle procedure, di una spersonalizzazione delle attività umane, percepibile in modo trasversale pressoché in tutti gli ambiti delle esperienze, dalla vita politica ai rapporti di lavoro, dalla formazione universitaria alla sanità pubblica.
Accade non in qualche romanzo distopico ma a Venezia – come mi è stato detto – che una persona, al cambio del medico, alla richiesta di un appuntamento “per farsi conoscere ed esporre la propria situazione generale” si senta rispondere: “Io non do appuntamenti per conoscere i pazienti: curo le loro malattie. Mi chiami quando avrà qualche problema e la riceverò”.
Si curano, dunque, le malattie, non le persone. Non interessa conoscerle, perché la relazione di cura si è dissolta nella logica degli impersonali protocolli, certo necessari per il fondamento scientifico della base statistica che si viene a precisare nel tempo circa l’efficacia delle procedure e la risposta dei pazienti, ma che, alla fine, prescindono totalmente dalla persona, dalla sua complessità e sensibilità singolare, dalla sua storia clinica, come se questi aspetti fossero del tutto irrilevanti agli effetti di una cura reale.
È evidente il distacco dall’esperienza e dalla realtà della vita, un distacco paradossale e contraddittorio se pensiamo quanto contemporaneamente si va dicendo, e giustamente, sulla necessità di una visione di complessità – multidisciplinare ed interdisciplinare – sulla produttività anche nel lavoro, su una qualità di vita che sia umana e di buone relazioni, sull’empatia e conoscenza di tutti gli aspetti – psicologici, culturali ed esistenziali – nelle relazioni di cura medico-paziente.
Ma c’è un’altra contraddizione: l’esperienza viva, dell’orizzonte elementare di senso, di un originario (la “natura”) che precede il soggetto che vi si radica e relaziona – additato da Havel come ciò da cui la modernità tecno-scientifica ci ha alienati -, diventa il mito di un sogno di riconquista di autenticità, quando viene considerato come l’ambito incontaminato di una vita rigenerabile, di un “ritorno alla natura”, oppure qualcosa di addirittura irricevibile, contrario alla vita stessa – al punto da dover essere respinta e negata anche contro evidenze elementari – quando si tratta di affermare una libertà che si vuole assoluta e incondizionata, ab-soluta, nel senso etimologico di sciolta da ogni vincolo, foss’anche la realtà stessa, iniziando dalla corporeità.
Ma se il mondo naturale di cui parla Havel è il Lebenswelt delle filosofie fenomenologiche ed esistenzialiste, a partire dal pensiero di Edmund Husserl – ossia, tradotto letteralmente, il “mondo della vita” o il “mondo vitale” –, allora questa natura non è altro che la realtà dell’esistenza nella sua concretezza, e dovremmo ricomporre tale contraddizione nell’unica comprensione dell’esperienza come ineludibilmente legata alla realtà.
Scrive ancora Havel: «Non dobbiamo vergognarci di essere capaci di provare amore, amicizia, solidarietà, compassione e tolleranza, ma esattamente l’opposto: dobbiamo liberare queste dimensioni fondamentali della nostra umanità dal loro esilio “privato” e accettarle come l’unico, genuino punto di partenza di una significativa comunità degli uomini. Dobbiamo farci guidare dalla nostra ragione e servire la verità, in tutte le circostanze, quale nostra fondamentale esperienza»[8].
La traiettoria della soggettività moderna – precipitata nel soggettivismo solipsistico – ha reso autoreferenziali anche le dimensioni sociali del vivere che si sono trovate ad essere null’altro che la proiezione di una soggettività individuale che è appagata in una consonanza quasi letterale dei propri pensieri, del proprio dire, dei codici comuni che finiscono col diventare vuoti e rassicuranti slogan dell’appartenenza ad una comunità di soggetti accomunati da un pensiero unico, quasi si trattasse dell’espressione di un soggetto singolare replicato per quanti sono i soggetti-fantasma che numericamente compongono il gruppo.
Talvolta non ne sono immuni le dinamiche interne di alcuni gruppi ecclesiali che, da risorsa della Chiesa del nostro tempo, sorge il dubbio che, talora, si traducano in rassicuranti nicchie nelle quali trovare la comfort-zone di un’intesa su un grappolo di assunti e stili di vita non problematici, fatti propri e da riconoscere come a sé congeniali, da emulare e replicare. Si finisce così per pervenire a forme di “normalizzazione” protocollare non molto diverse dai costrutti per astrazione della cultura tecno-scientifica che, con l’oggettivare la vitalità dell’esperienza prescindendo dalla sua complessità, rendono non autentica l’esistenza concreta.
Curioso paradosso della contemporaneità: il massimo soggettivismo dilatato all’inverosimile che si esprime in soggettivismo sociale e si traduce nella massificazione di una libertà sciolta da ogni vincolo perché pensata come dominio assoluto dell’Io, e così la libertà si vanifica nel suo opposto.
Siamo dinanzi all’impetus soggettivistico e spersonalizzante dell’identità e del pensiero, per cui dove risulta massimo l’impulso di una libertà fuori controllo, tale da ergersi contro le stesse coordinate essenziali della realtà e della vita – un tempo avremmo detto, senza timore d’esser fraintesi, della natura –, ebbene, tali coordinate sono percepite come condizionamenti limitanti e frustranti e non come condizioni dell’esserci e, quindi, della stessa possibilità di vivere, pensare e agire per il bene, senza le quali nulla sarebbe possibile; eppure tale impetus soggettivistico sembra più forte che mai. Al punto da porsi contro la stessa appartenenza vitale e le proprie radici, il proprio ambiente, la propria esistenza, la propria cultura.
È così in atto un processo per cui la civiltà occidentale avrebbe prodotto quanto di peggio la società umana ha espresso nella sua storia plurimillenaria. La degenerazione di tale processo ha portato negli ultimi anni – al limite del grottesco – alla retorica del “politicamente corretto”, agli eccessi della cosiddetta cancel culture e all’ideologia woke, con operazioni avulse dalla comprensione del contesto storico e culturale in cui determinate realizzazioni artistiche e del pensiero sono venute alla luce, e in cui possiamo riconoscere, ancora una volta, l’espressione di quella spinta che astrae dalla complessità del reale e dalla vita stessa e non è neppure in grado di incontrarla e di parlare al cuore dell’uomo.
In una conferenza tenuta a Madrid nel novembre 2024, il filosofo francese Rémi Brague – specialista nel pensiero islamico, ebraico e cristiano del Medioevo – si è interrogato sull’origine e il significato dell’odio di sé maturato dall’uomo occidentale nella tarda modernità, diagnosticandone le cause nell’astrazione dalla realtà quale esito di una libertà concepita come assoluta volontà di autodeterminazione in tutte le dimensioni dell’essere e del vivere. E ha affermato: «Ha l’uomo postmoderno il sogno impossibile di una autodeterminazione radicale di sé e per sé, di un’anima che sorvola la realtà e si posa sul corpo che sceglie, sull’epoca che decide, sul luogo che preferisce, ecc. Per questo, il soggetto e l’oggetto di tale amore sono una punta fine dell’individualità in cui non c’è esistenza concreta, cioè carnale e storica. Ama ciò che vorrebbe che fosse, odia ciò che è, tutto ciò che fa, ciò che è»[9].
Secondo Brague, l’odio di sé dell’uomo occidentale sarebbe generato da una forma di “auto-invidia” che porterebbe con sé un desiderio di autodistruzione che, a sua volta, costituirebbe «la forma più perfetta dell’autodeterminazione», giacché, continua il pensatore francese, «l’odio verso sé stessi dell’uomo occidentale non ha come oggetto l’individuo nel suo nucleo fondamentale, ma piuttosto tutto ciò che lo determina dall’esterno»[10].
In effetti, nella scissione di tutti i legami di senso con ciò che lo precede e lo circonda, con tutti i significati del vivere dotati di una qualche stabilità, il soggetto ritiene di conseguire la massima libertà. Una libertà pensata in astratto, concepita per assenza di proposte sostantive di senso, che è propriamente il cuore del nichilismo contemporaneo, e si riflette nel fraintendimento del principio di laicità inteso come neutralizzazione/assenza nel campo della vita pubblica di ogni connotazione di senso religioso storicamente determinato che rimandi alla trascendenza come orizzonte ultimo. Progetta così, più o meno inconsciamente, il proprio sradicamento. Come se una pianta potesse vivere dopo essersi sottratta al terreno che la nutre.
Simone Weil, nell’opera L’enracinement, tradotta in Italia col titolo La prima radice, riconosce nel radicamento (come suona alla lettera il titolo originale) «forse il bisogno più importante e misconosciuto dell’anima umana», «tra i più difficili a definire»[11]. E ne restituisce il significato in questi termini: «Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all’esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l’essere umano ha una radice. Partecipazione naturale, cioè imposta automaticamente dal luogo, dalla nascita, dalla professione, dall’ambiente. Ad ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente»[12].
Sulla scorta di questa nozione di radicamento, è la stessa Weil a riconoscere nello sradicamento la patologia più grave dell’uomo dell’Europa a lei contemporanea, che consisterebbe nella distruzione del rapporto pieno e vissuto con le coordinate elementari dell’esperienza, il proprio tempo, il proprio spazio vitale, la propria storia e il proprio ambiente naturale, da cui dipenderebbero gli stati di discontinuità e frammentazione che conosciamo, in una parola quella generale estraniazione che abbiamo considerato all’inizio come condizione di smarrimento pervasivamente sperimentata.
Di diverso avviso è il filosofo francese François Jullien che, secondo il punto di vista del non credente, quale egli stesso si dichiara, respinge le nozioni di “radici” e “identità”, in quanto, a suo dire, affette da una visione autoreferenziale, identitarista, e propone di riconsiderare il cristianesimo quale “risorsa” che più fedelmente ne rifletterebbe l’apertura universale e che considera ben attestata negli scritti neotestamentari, soprattutto in Paolo, in cui riconosce l’istanza di un “positivo” sradicamento dal particolarismo dell’essere storicamente e culturalmente situati, sulla spinta della vocazione a quell’universalità dell’umano che della fede cristiana costituirebbe uno dei tratti più originali e fecondi[13].
Le due prospettive, però, non si escludono in quanto la stessa Simone Weil – in un ambito del tutto sconosciuto a François Jullien – acconsente alla “positività” dello sradicamento volontario di ciò che riduce all’interesse particolare così come si riscontra nella spiritualità e nella mistica cristiana che – attraverso percorsi di solitudine rivolti all’Amore di Dio e al Bene universale – recuperano la possibilità di legami autentici e di un nuovo e più vero radicamento che, a questo punto, non sarebbe altro che la riunificazione del mondo e la ricomposizione del senso del fondamento del Bene, cioè dell’essere stesso di Dio, vero, unico, universale, assoluto, e come tale, il solo capace d’incontrare l’uomo nella sua vita reale, unico a garantire la ricostruzione di una trama di autentiche relazioni, in cui si dà rinnovato e vero radicamento.
La cultura occidentale europea che ha operato la sintesi fra Atene, Gerusalemme e Roma – articolandone pensiero e motivazioni – s’identifica nell’universalità dei valori e princìpi che esprimono l’umano di ogni tempo e di ogni luogo a partire dalla dignità intangibile della persona. Almeno in quello che è lo “strato” fondamentale di tali valori e principi, sotto il quale si liquiderebbe l’umanità stessa, non considerando – fra l’altro – la straordinaria pluralità di culture e sensibilità che si sono affermate nella storia, ciascuna delle quali restituisce alcune sfumature che costituiscono, pure, il senso di attuali contraddizioni, a partire dall’aporia di una libertà che si rivolge contro la storia della sua stessa liberazione e progetta la rimozione del suo fondamento intangibile e assoluto.
L’uomo di oggi non manca di tutte le spinte interiori profonde capaci di orientarlo ancora al Vero e al Bene, e ad incontrare attraverso di essi – nell’unità fondamentale dell’esperienza che da moderni chiamiamo soggetto e che dovremmo chiamare persona – l’Unità dell’essere di Dio, che lo trascende e che costituisce il riferimento ultimo di senso, senza il quale straripa quella visione nichilista che si ritorce, infine, nell’auto-delegittimazione dell’uomo contemporaneo e nell’atteggiamento autodistruttivo, nell’odio di sé, nella decostruzione di tutto, fino al sostrato della natura stessa che lo precede e lo nutre, come prodotto di una cultura avvertita come “limite condizionante”, anziché come “condizione d’esserci” e come tale da ripudiare e rimuovere.
Non manca, certo, la spinta alla Verità e al Bene, perché ad essi è in fondo rivolto il cuore dell’uomo, recando in sé – fin dalla creazione – l’impronta del Verbo, il Volto di Cristo. E lo si coglie nelle innumerevoli e talora sorprendenti esperienze in cui avvertiamo sussulti di autentica umanità, di buone relazioni, di aiuto e di cura, di una “carità naturale”, per dir così, mossa da un naturale orientamento che al fondo del cuore dell’uomo sa ancora riconoscere la direzione del bene e desiderarlo.
Ritornando al discorso di Václav Havel, si tratterebbe allora, oggi, di riuscire «a ricostruire il mondo naturale come vero terreno della politica, a riabilitare l’esperienza personale degli uomini come misura prima delle cose, ponendo la moralità sopra la politica e la responsabilità al di sopra dei nostri desideri, a dare significato alla comunità degli uomini, a restituire il contenuto al linguaggio umano, a ricostituire l’“Io”-uomo, autonomo, integrale, dignitoso, come fulcro di tutta l’azione sociale, responsabile per noi stessi, perché siamo legati a qualcosa di più grande e capace di sacrificare qualcosa, in casi estremi anche tutto, della sua prosperosa e banale vita privata […] per il bene di ciò che dà significato alla vita»[14].
Le ragioni di speranza, e non per un futuro astrattamente migliore, ma per un rinnovato vissuto di realtà saldamente ancorato all’esperienza e alle coordinate fondamentali di orientamento esistenziale, sono ancor oggi riposte in questa capacità di universalità che è capacità di Verità, di Bontà, di Bellezza e, attraverso queste, di Dio, che qualifica nell’intimo il cuore dell’uomo, anche quando sembra dirottarsi dalle sue fonti primarie di senso e perdersi inseguendone le fuorvianti apparenze.
In un discorso incentrato sull’Europa, pronunciato nel maggio 2016, Papa Francesco auspicava «un nuovo umanesimo europeo, “un costante cammino di umanizzazione”, cui servono “memoria, coraggio, sana e umana utopia”» e così lo esplicitava ulteriormente: «Sogno un’Europa giovane, capace di essere ancora madre: una madre che abbia vita, perché rispetta la vita e offre speranze di vita. Sogno un’Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e chi arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un’Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno un’Europa, in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito ad un maggior impegno con la dignità di tutto l’essere umano. Sogno un’Europa dove i giovani respirano l’aria pulita dell’onestà, amano la bellezza della cultura e di una vita semplice, non inquinata dagli infiniti bisogni del consumismo; dove sposarsi e avere figli sono una responsabilità e una gioia grande, non un problema dato dalla mancanza di un lavoro sufficientemente stabile. Sogno un’Europa delle famiglie, con politiche veramente effettive, incentrate sui volti più che sui numeri, sulle nascite dei figli più che sull’aumento dei beni. Sogno un’Europa che promuove e tutela i diritti di ciascuno, senza dimenticare i doveri verso tutti. Sogno un’Europa di cui non si possa dire che il suo impegno per i diritti umani è stato la sua ultima utopia»[15].
In conclusione, se ora torniamo là da dove siamo partiti, ossia ai vent’anni di vita della nostra Facoltà Teologica, desidero ringraziare tutte le donne e gli uomini che si sono succeduti in questi anni, nell’ambito del governo della Facoltà, della ricerca, della didattica, dell’amministrazione, ai diversi livelli, in particolare gli studenti – chierici, consacrati/e, laici – : è per loro che la Facoltà è stata costituita e vive a servizio non solo delle nostre Chiese ma, anche, del nostro territorio, della nostra gente, perché la cultura sia sempre in grado di interpellare e interessare tutte le dimensioni e le corde dell’’uomo; tutte, nessuna esclusa.
Rinnovo l’augurio affinché la Facoltà Teologica del Triveneto sappia farsi interprete della verità dell’uomo del nostro tempo che è l’uomo di sempre nella luce di Dio. Ed è proprio alla luce che Papa Francesco ha paragonato la teologia, in un discorso tenuto il 9 dicembre 2024 ai partecipanti al Congresso internazionale dedicato alle sue prospettive future: «Quando penso alla teologia – ha affermato – mi viene in mente la luce. […] La luce è discreta, è gentile, è umile e, perciò, rimane invisibile. È gentile la luce. Così è anche la teologia: fa un lavoro nascosto e umile, perché emerga la luce di Cristo e del suo Vangelo»[16].
Mi viene alla mente qui il poema o, meglio, la preghiera composta da John Henry Newman, il grande teologo del XIX secolo che, per il suo pensiero attualissimo e a considerare la sua opera teologica e la sua vita, oggi, per molti, presenta i requisiti per essere annoverato fra i dottori della Chiesa. Questa preghiera fu scritta in un momento difficile della sua vita ed è universalmente conosciuta come Lead, Kindly Light – Guidami tu, Luce Gentile –, dove la Luce gentile è lo stesso Dio[17].
Nel vissuto della comunità di docenti e studenti, la Facoltà Teologica – stando ad un’altra felice espressione del nostro Pontefice – aiuta a «fermentare insieme la forma del pensiero teologico con quella degli altri saperi»[18]. La nostra Facoltà possa essere luce gentile e irradiante, andando anche oltre l’ambito di coloro che partecipano a percorsi di formazione accademica e, per tutti, si ponga come strumento d’intelligenza della fede per gustare la bellezza delle cose di Dio in una reale e gioiosa immersione nella vita di grazia.
[1] Cfr. 1Cor 2,16.
[2] A. Rosmini, Lettera a Giuseppe Aimo, novembre 1845, in Epistolario completo, vol. IX, Casale Monferrato, 1892, Lett. 5165, p. 100.
[3] Cfr. H. Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil, trad. it.: La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, trad. di P. Bernardini, Milano, Feltrinelli, 1964.
[4] Cfr. E. Mastrangelo – E. Petrucci, Iconoclastia. La pazzia contagiosa della cancel culture che sta distruggendo la nostra storia, Massa, Eclettica, 2020; C. Rizzacasa D’Orsogna, Scorrettissimi. La cancel culture nella cultura americana, Roma – Bari, Laterza, 2022.
[5] Agostino, Confessioni, III, 6, 11.
[6] V. Havel, La politica dell’uomo, trad. it. di M.G. Simbula, Roma, Castelvecchi, 2014, p. 13.
[7] Ivi, pp. 14-15.
[8] Ivi, p. 44.
[9] R. Brague, ¿Porque el hombre occidental se odia a sí mismo?, Madrid, Fundación Neos, 18 novembre. – https://www.nuevarevista.net/por-que-el-hombre-occidental-se-odia-a-si-mismo/; trad. it.: https://www.ilfoglio.it/cultura/2024/11/30/news/perche-l-uomo-occidentale-si-e-ridotto-a-odiare-se-stesso-7187000/ .
[10] Ibid.
[11] S. Weil, La prima radice. Preludio ad una dichiarazione dei doveri verso l’essere umano, trad. di F. Fortini, Milano, SE, 1990, p. 49.
[12] Ibid.
[13] F. Jullien, Risorse del cristianesimo. Ma senza passare per la via della fede, Milano, Ponte alle Grazie, 2019.
[14] V. Havel, La politica dell’uomo, cit., p. 36.
[15] Francesco, Discorso al Conferimento del Premio Internazionale Carlo Magno 2016 a Sua Santità Papa Francesco, Palazzo Apostolico Vaticano, 6 maggio 2016. – https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/05/06/0319/00735.html .
[16] Francesco, Ai partecipanti al Congresso Internazionale sul futuro della Teologia promosso dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, 9 dicembre 2024.
[17] J.H. Newman, Apologia pro vita sua, Milano, Jaka Book, p.63.
[18] Francesco, Ibid.